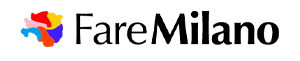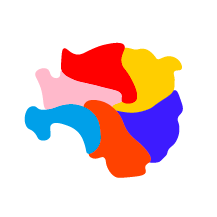La Metropoli dei Quartieri
Sintesi del primo confronto pubblico di Fare Milano sul tema La Metropoli dei quartieri di Lunedì 19 ottobre.
Non sarà un virus a decretare la fine delle città - o di Milano.
Dopo una settimana di incontri, con 12 tavoli di lavoro e oltre 200 partecipanti, il Centro Studi PIM ha presentato quanto emerso da questi primi confronti, aprendo la riflessione agli ospiti intervenuti e a tutta la città.
Non sarà quindi il covid-19 o il lavoro a distanza a segnare la fine delle città. La pandemia ha fatto però emergere dei trend, accentuando e al tempo stesso riconfigurando, fragilità in parte già presenti nella Milano pre-Covid. Il Covid aumenterà i divari economici, sociali e territoriali e le politiche pubbliche avranno un fondamentale ruolo di regia nella gestione di questi spostamenti e nella ripresa della città. Il governo del territorio può essere determinato da nuove regole o da grandi interventi infrastrutturali e funzionali, che stimolano dinamiche territoriali economiche e sociali.
Ripartendo dalle regole, il PGT (Piano di Governo del Territorio) e il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) sono l’eredità del lavoro fatto negli ultimi 10 anni. Una visione da cui ripartire e su cui installare un nuovo Progetto di Città, in cui innovazione e attrattività convivano con inclusione ed equità. Un nuovo progetto di città che dovrà rispondere con prontezza, adattività e reversibilità di fronte all’incertezza degli sviluppi futuri. Una visione sistemica, sequenziale e transcalare su cui si inseriscano partnership pubblico private su progettualità che sappiano rispondere realmente ai bisogni dei territori.
I confini del comune non bastano più. Il progetto di città dovrà coinvolgere la Milano metropolitana e per farlo ci sarà bisogno anche di strumenti a livello amministrativo che permettano il coordinamento efficace dei diversi attori e il governo effettivo del territorio. Come ricordato da Paolo Mazzoleni, Presidente dell’Ordine degli Architetti, benché la scala su cui lavorare possa variare - l’area urbana di Milano varia dai 3, 4 agli 8 milioni di persone a seconda dei servizi e delle funzioni considerati – sarà fondamentale il coordinamento del Comune di Milano con i comuni limitrofi e gli altri enti territoriali, verso un progetto di città inclusivo, capace di trainare e ispirare anche i territori circostanti, come evidenziato anche da Michela Palestra, Sindaca di Arese e Presidente del Parco Agricolo Sud.
A livello metropolitano sarà poi centrale il tema della sostenibilità delle scelte di sviluppo territoriale: nella gestione delle infrastrutture verdi e blu, in progettualità sistemiche come la creazione di un Parco metropolitano, nei grandi progetti di ridefinizione del paesaggio, la cui risanazione ambientale deve diventare un obiettivo condiviso, così come nel sistema dei trasporti, in cui il trasporto rapido di massa, la desincronizzazione degli orari e l’integrazione digitale della piattaforme saranno elementi chiave per un trasporto sostenibile e intermodale che sappia coinvolgere tutta l’area metropolitana nel superamento di una visione auto-centrica degli spostamenti. Su quest’ultimo tema Federico Parolotto, Senior Partner di Mobility in Chain, ha sottolineato come la rapidità dell’amministrazione comunale nell’intervenire con soluzioni alla crisi, come il piano di estensione delle piste ciclabili, abbia permesso a Milano di tornare tra le eccellenze nel panorama internazionale. Il cambio però non dovrà limitarsi alle aree più dense, ma anche nell’area urbana, potenziando il trasporto pubblico, anche senza dover ricorrere obbligatoriamente a nuove linee della metropolitana, ma guardando a trasporto leggero su rotaia o al trasporto pubblico su gomma.
Sarà centrale il tema delle funzioni e del mix funzionale nei quartieri. Il covid ha evidenziato la fragilità tanto in centro, con la desertificazione – temporanea - degli uffici, quanto in periferia, con la crisi del modello del centro commerciale, meno raggiungibile quando le possibilità di spostamento sono limitate. Ha anche segnalato come una riorganizzazione degli spazi e dei consumi, possa riattivare quartieri da sempre considerati dormitorio. Ancora, lo spegnimento temporaneo di anchor institutions, come le università, ne ha mostrato il ruolo e l’importanza vitale in alcuni quartieri. Nuove grandi funzioni urbane a servizio della città possono essere il motore di sviluppo di aree che sono in ricerca di nuovi stimoli o generatori di processi di modernizzazione, utili a tutto il paese. In questo senso le Olimpiadi 2026, potranno essere un catalizzatore di investimenti in una direzione comune, utile alla città.
Emerge con forza il tema della città a 15 minuti e della prossimità. Un nuovo modo di prendersi cura del territorio, in cui l’urbanistica tattica continuerà ad essere lo strumento principe per acdcelerare il processo di rendere lo spazio pubblico sempre più fruibile per i cittadini. Quartieri in cui i servizi e nuovi spazi ibridi, in cui vita sociale e lavoro si possono incontrare siano accessibili a tutti in termini di distanza ma anche in termini di accessibilità economica, con una maggiore quota di case in affitto e la promozione di una sempre maggiore mixité sociale. Il nuovo paradigma del lavoro smart, se effettivamente lo diventerà, dovrà separarsi dalla dimensione domiciliare e trovare nuovi luoghi di ricomposizione e di relazione, nel pubblico - biblioteche, centro civici, riuso del patrimonio pubblico dismesso e sotto utilizzato – e nel privato a fini pubblici, ad esempio nel riutilizzo dei piani terra. Gli interventi di Janette Sadik-Khan, Principal di Bloomberg Associates, e Carlos Moreno, fondatore di Human Smart Cities, sposano questa linea. Città capaci di riprendersi le proprie strade e mai spaventate dalla partecipazione dei cittadini. Sostenere il superamento del predominio delle auto nelle strade nelle aree più dense e fornire alternative valide a chi oggi ha nell’auto l’unico modo di spostarsi.
La rigenerazione urbana passerà anche dal coraggio nella riqualificazione e nel rinnovo del patrimonio edilizio cittadino, un processo che non può avvalersi degli strumenti leggeri dell’urbanistica tattica, ma che deve saperne mutuare la capacità di coinvolgere e convincere i residenti. Le agenzie di quartiere possono essere una soluzione alla necessità di una regia e un accompagnamento delle politiche di prossimità, seguendo i modelli formali e informali che già oggi organizzano la vita di quartiere, in particolare di quelli periferici. L’innovazione che nasce al loro interno deve essere in condizione di esplodere in tutta la città.
La dimensione dei quartieri può permettere a Milano di superare la cerniera che separa il comune da ciò che lo circonda, in un nuovo paradigma policentrico, che segua anche la visione con cui erano stati immaginati per il PGT del 2010 gli 88 quartieri o NIL - Nuclei di Identità Locale, come ricordato da Nicola Russi di Laboratorio Permanente. Una costellazione metropolitana di quartieri che superi la scala comunale e raggiunga l’area metropolitana anche nel diritto a servizi, a una scuola, a un parco, a un giardino, a uno spazio pubblico fruibili entro 15 minuti. Un progetto di città diversificata e adattabile nelle forme e nelle regole all’incertezza del futuro.
Sono intervenuti: Franco Sacchi (Centro Studi PIM), Pierfrancesco Maran (Assessore all'Urbanistica), Piero Bassetti (Globus et Locus), Janette Sadik-Khan (Bloomberg Associates), Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università Milano Bicocca), Marco Granelli (Assessore Mobilità e Lavori Pubblici), Federico Parolotto (Mobility in Chain), Michela Palestra (Sindaco Arese), Maria Chiara Pastore (Politecnico di Milano), Paolo Mazzoleni, Francesco Romussi (CONI Milano Cortina 2026), Regina de Albertis (ANCE giovani), Benedetto Giustiniani (Generali Real Estate), Patricia Viel (Citterio-Viel), Carlos Moreno, Nicola Russi (Laboratorio Permanente), Federica Verona (SUPER), Davide Fassi (Politecnico di Milano), Demetrio Scopelliti (AMAT).